I remember you well in the Chelsea Hotel
you were talking so brave and so sweet
giving me head on the unmade bed
while the limousines wait in the street.
Those were the reasons and that was New York
we were running for the money and the flesh
And that was called love for the workers in song
probably still is for those of them left.
Ah but you got away didn't you baby
you just turned your back on the crowd
You got away I never once heard you say
I need you, I don't need you
I need you, I don't need you
and all of that jiving around.
I remember you well in the Chelsea Hotel
you were famous your heart was a legend
You told me again you preferred handsome men
but for me you would make an exception.
And clenching your fist for the ones like us
who are oppressed by the figures of beauty
You fixed yourself you said: "Well, never mind
we are ugly but we have the music".
And then you got away didn't you baby
you just turned your back on the crowd
you got away I never once heard you say
I need you, I don't need you
I need you, I don't need you
and all of that jiving around.
I don't mean to suggest that I loved you the best
I can't keep track of each fallen robin
I remember you well in the Chelsea Hotel
that's all I don't think of you that often.
Mi ricordo bene di te, al Chelsea Hotel,
di come parlavi, così coraggiosa e dolce,
o mentre mi facevi un pompino sul letto sfatto,
con le limousine giù in strada ad aspettare.
Quelle erano le ragioni e quella era New York,
era per i soldi che correvamo, e per la carne.
E quello era ciò che i lavoratori della canzone chiamavano 'amore',
e probabilmente lo chiamano ancora così, quelli di loro che sono rimasti.
Ah ma tu te ne sei andata, vero piccola?
Hai semplicemente voltato le spalle alla folla.
Te ne sei andata, e non una sola volta che ti abbia sentito dire
"Ho bisogno di te, non ho bisogno di te,
Ho bisogno di te, non ho bisogno di te"
e stronzate simili.
Mi ricordo bene di te, al Chelsea Hotel, eri famosa,
il tuo cuore era una leggenda.
Continuavi a ripetermi che preferivi gli uomini belli
ma che per me avresti fatto un'eccezione.
E serrando il pugno rabbiosamente per quelli che, come noi,
sono oppressi dalle forme della bellezza,
ti bloccavi dicendo: "Bé, non importa,
noi siamo brutti ma abbiamo la musica!"
Ah ma tu te ne sei andata, vero piccola?
Hai semplicemente voltato le spalle alla folla,
te ne sei andata, e non una sola volta che ti abbia sentito dire
“Ho bisogno di te, non ho bisogno di te,
Ho bisogno di te, non ho bisogno di te"
e stronzate simili.
Non voglio far credere di averti amata perdutamente,
e non è che io possa tener conto di ogni pettirosso caduto.
Mi ricordo bene di te al Chelsea Hotel,
tutto qui, non ti penso neanche troppo spesso.
[Leonard Cohen, Chelsea Hotel #2]

Ieri mi è capitata una cosa.
Ve la faccio breve. In questi ultimi giorni stavo pensando di dedicare qualche riga ad una canzone che amo tantissimo,
Chelsea Hotel #2 di Leonard Cohen.
Bene. Apro l'ultimo numero de IL MUCCHIO SELVAGGIO, 640, novembre 2007 e che ti trovo? Un articolo di Alberto Crespi su
Chelsea Hotel #2. Telepatia? Mah... Mai conosciuto Crespi.
Confesso che ho mollato un bel paio di bestemmioni. Dato che qualcuno, dai e dai, comincia a visitarlo, questo blog verbosissimo e snob, non vorrei che si pensasse, perdiana, che l'ispirazione per quello che scrivo sia, come dire, un pochino indotta. Lo è, purtroppo, per i post ispirati dalla (deprimente realtà della) politica. Non è così per quello che faccio uscire su scrittori, poeti, pittori, film e canzoni. Giurin giurello.
E insomma, Chelsea Hotel #2.
Nelle note di copertina del suo Greatest Hits del 1975, Leonard Cohen scrisse che la canzone iniziò a scriverla al bancone del bar di un ristorante polinesiano a Miami, nel 1971, e la terminò ad Asmara, nel regno d'Etiopia, poco tempo prima che il Negus Neghesti venisse rovesciato da Menghistu. Annotò Cohen: “I wrote this for an American singer who died a while ago”.
La canzone fu registrata nel 1974 durante le sessions dell'album che Cohen pubblicò in quell'anno, New Skin for the Old Ceremony, ma venne presentata dal vivo già il 23 marzo del 1972, alla Royal Albert Hall, a Londra.
Ha un testo bellissimo. Parole che fanno male, che ti strappano il cuore, soprattutto quando, ascoltandole, si pensa
a chi sono dedicate.

Cohen visse a lungo al Chelsea Hotel. Il posto gli piaceva. Una volta disse che era il genere di luogo nel quale, alle quattro del mattino, potevi portarti in camera un nano, un orso e quattro signore senza che ci fosse qualcuno che dicesse 'ba': perché non c'era proprio nessuno, lì intorno, a cui sarebbe importato qualcosa.
Stanley Bard, per anni direttore del Chelsea, qualche anno or sono ricordò che, tra la gente che visse nell'albergo nel corso dei tumultuosi anni Sessanta, Leonard Cohen era stata una delle poche persone sempre calme e tranquille. Almeno apparentemente. “
But perhaps his restlessness was better hidden than that of the others” (saggiamente: “forse la sua irrequietudine era semplicemente meglio nascosta rispetto a quella di altri”). “
Most of his time in New York in the Sixties – continua Bard -
he was living at # 424”.
Janis Joplin – perché è lei la cantante americana di cui Cohen canta in
Chelsea Hotel #2 – di solito alloggiava nella suite 411.
Nella canzone, immagini di New York alla fine dei Sessanta, immagini di una star il cui cuore era, in quel momento, una leggenda (trasparente allusione a
Piece of my heart di Bert Berns di cui Janis aveva proposto una cover travolgente in
Cheap Thrills), immagini di una persona oppressa dalle tante forme che la bellezza può assumere (“un brutto anatroccolo vestito da principessa”: così Chrissie Hynde) e che perciò si fa prendere talvolta dalla rabbia e poi fanculo, si scuote e dice, orgogliosa e dolce: “
Well, never mind. We're ugly but we have the music” (Bé, non importa. Noi siamo brutti, ma abbiamo la musica). E su quel “
well, never mind” a me è sempre parso che Cohen, cantando, avesse abbassato la voce fin quasi al sussurro per
imitare la voce di Janis.
Leonard Cohen, proprio come la famosa cantante americana il cui cuore era una leggenda, in quegli anni mozzafiato correva come un pazzo per i soldi, e per la carne (non “ for the meat”, la carne del macellaio, ma “for the flesh”, i corpi, il sesso). Durante una di quelle corse si imbattè in lei. E finirono insieme per qualche giorno, solo per qualche giorno. Un amore al Chelsea Hotel.
Le ultime parole della canzone sono un anticlimax incredibilmente lapidario, dopo la dolcezza del ricordo. Ma non sono d'accordo con Alberto Crespi che sull'ultimo MUCCHIO ha parlato di “ricordo non del tutto gradevole”.
Cohen scrisse
Chelsea Hotel #2 qualche mese dopo la morte di Janis. Voleva ricordare quel “pettirosso caduto” semplicemente, senza retorica. Perciò spense la sua canzone così, come si spegne la fiamma di una candela.
Era consapevole del fatto che stava cantando di una persona che sul palco faceva “l'amore con ventimila persone” e poi tornava sempre a casa da sola. Perciò non voleva far credere chissà cosa. Perché Janis non meritava menzogne o piccinerie.
In un'intervista rilasciata nel 1988 Leonard Cohen dichiarò che
Chelsea Hotel #2 era “una riflessione accurata del processo emozionale. Scrivi una canzone che ti coinvolge emotivamente, giungi alla fine e ti rendi conto che non rappresenta tutta la tua vita, che non è la cosa più importante della tua esistenza, non è la donna dei tuoi sogni. Sono convinto che anche lei, Janis Joplin, la ragazza che ho incontrato al Chelsea Hotel e a cui è dedicato il brano, avrebbe apprezzato il modo in cui è finito, quegli ultimi versi”.
Quando si scrive qualcosa, il problema è sempre concludere.
E allora concludo ringraziando un grandissimo poeta. Ogni volta che ascolto la sua canzone mi ricordo del fatto che Janis Joplin è e sarà per sempre un pezzo del mio cuore.










 Che Aue appaia come un nazista, come dire, un po' fuori norma, qualcuno lo ha fatto notare, a Jonathan Littell. Che si è detto d'accordo: “Ma un nazista sociologicamente credibile non avrebbe mai potuto esprimersi come il mio narratore. Non sarebbe mai stato in grado di fare luce sugli uomini che lo circondano. Quelli che sono esistiti come Eichmann o Himmler, e quelli che ho inventato io. Max Aue è un raggio X che esplora, uno scanner. Effettivamente non è un personaggio verosimile. Non cercavo la verosimiglianza, ma la verità. Non vi è romanzo possibile se ci si aggrappa al solo registro della verosimiglianza. La verità romanzesca è di un altro ordine rispetto a quella storica o sociologica”. Sostiene Littell. E mi può andare bene. Solo che io non sono tanto sicuro del fatto che Herr Aue non sia un personaggio verosimile.
Che Aue appaia come un nazista, come dire, un po' fuori norma, qualcuno lo ha fatto notare, a Jonathan Littell. Che si è detto d'accordo: “Ma un nazista sociologicamente credibile non avrebbe mai potuto esprimersi come il mio narratore. Non sarebbe mai stato in grado di fare luce sugli uomini che lo circondano. Quelli che sono esistiti come Eichmann o Himmler, e quelli che ho inventato io. Max Aue è un raggio X che esplora, uno scanner. Effettivamente non è un personaggio verosimile. Non cercavo la verosimiglianza, ma la verità. Non vi è romanzo possibile se ci si aggrappa al solo registro della verosimiglianza. La verità romanzesca è di un altro ordine rispetto a quella storica o sociologica”. Sostiene Littell. E mi può andare bene. Solo che io non sono tanto sicuro del fatto che Herr Aue non sia un personaggio verosimile.




 Sono fantastici, i miti e i riti dei duri e puri (dei miei coglioni) della sinistra che non transige. Fantastici davvero. I più tosti tra loro sono capaci di presentarsi in testa ai cortei vestiti da kamikaze delle Brigate Martiri di al-Aqsa. Ma questa è roba veramente hardcore: per pochi, quindi.
Sono fantastici, i miti e i riti dei duri e puri (dei miei coglioni) della sinistra che non transige. Fantastici davvero. I più tosti tra loro sono capaci di presentarsi in testa ai cortei vestiti da kamikaze delle Brigate Martiri di al-Aqsa. Ma questa è roba veramente hardcore: per pochi, quindi.



 E, già che ci siamo, date un'attenta occhiata al secondo scatto pubblicato e dite: a cosa stava pensando Nostra Signora degli Zombies? (non mi rispondete, per piacere: "Stava pensando alla fava!". Vi cestinerei)
E, già che ci siamo, date un'attenta occhiata al secondo scatto pubblicato e dite: a cosa stava pensando Nostra Signora degli Zombies? (non mi rispondete, per piacere: "Stava pensando alla fava!". Vi cestinerei)
 Oggi quer ber pupone de Francesco Rutelli si chiede: "La Bella Italia è diventata generalmente più brutta?". Beh, si... Io, nel mio piccolo, direi di si. Assomiglia moltissimo agli italiani, d'altronde. I quali, lasciatemelo dire, fanno cagare veramente tanto, e ogni giorno un po' di più.
Oggi quer ber pupone de Francesco Rutelli si chiede: "La Bella Italia è diventata generalmente più brutta?". Beh, si... Io, nel mio piccolo, direi di si. Assomiglia moltissimo agli italiani, d'altronde. I quali, lasciatemelo dire, fanno cagare veramente tanto, e ogni giorno un po' di più.

 John Garfield, straordinario attore, dichiarò di non essere membro del Partito e di considerare il comunismo una tirannia, ma non fece mai i nomi di possibili comunisti. Ne avrà stroncata la carriera e nel 1951 morirà per un attacco di cuore, mentre era a letto con una puttana, la notte prima di un interrogatorio a Washington: una di quelle gogne pubbliche a cui furono costrette tantissime vittime della Commissione.
John Garfield, straordinario attore, dichiarò di non essere membro del Partito e di considerare il comunismo una tirannia, ma non fece mai i nomi di possibili comunisti. Ne avrà stroncata la carriera e nel 1951 morirà per un attacco di cuore, mentre era a letto con una puttana, la notte prima di un interrogatorio a Washington: una di quelle gogne pubbliche a cui furono costrette tantissime vittime della Commissione. Nel suo momento umanamente e professionalmente più difficile, Robert Rossen non rinunciò a dirigere, sceneggiare e produrre All the King's Men, riadattando per il grande schermo il romanzo di Robert Penn Warren ispirato alle gesta di Kingfish Long. In Tutti gli uomini del Re, Long si chiama Willie Stark, ambizioso avvocato che arriva a farsi eleggere governatore di un imprecisato stato del sud degli States e che per attuare il suo programma non esita a usare ogni mezzo necessario.
Nel suo momento umanamente e professionalmente più difficile, Robert Rossen non rinunciò a dirigere, sceneggiare e produrre All the King's Men, riadattando per il grande schermo il romanzo di Robert Penn Warren ispirato alle gesta di Kingfish Long. In Tutti gli uomini del Re, Long si chiama Willie Stark, ambizioso avvocato che arriva a farsi eleggere governatore di un imprecisato stato del sud degli States e che per attuare il suo programma non esita a usare ogni mezzo necessario.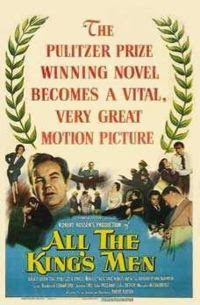 Uno dei migliori film politici nella storia del cinema americano. Straordinario nella rappresentazione cruda e disincantata dei dirty tricks della politica, brutalmente realistico nel racconto - privo di qualsiasi consolazione - dei meccanismi di gestione del potere. Una parabola totalmente disillusa (ma non cinica) sull'ambizione umana.
Uno dei migliori film politici nella storia del cinema americano. Straordinario nella rappresentazione cruda e disincantata dei dirty tricks della politica, brutalmente realistico nel racconto - privo di qualsiasi consolazione - dei meccanismi di gestione del potere. Una parabola totalmente disillusa (ma non cinica) sull'ambizione umana.








 un trenino di auguri dal verro Napoleon e da sua moglie E.
un trenino di auguri dal verro Napoleon e da sua moglie E.








 Nella numero 100 Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, uccise la sua fidanzata Nancy Spungen. Una storia d'amore finita, ahi ahi ahi, malissimo, a differenza di quella che, negli anni Sessanta, unì per poche notti soltanto Leonard Cohen e Janis Joplin e alla quale il cantautore canadese dedicò Chelsea Hotel n. 2. E infine, parlando d' amore, c'è Bob Dylan (poteva mancare una citazione per il signor Zimmerman, nel blog del tic?) che sul letto della suite principale del Chelsea scrisse una delle sue più belle canzoni, Sad eyed lady of the Lowlands, dedicata alla sua prima moglie Sara Lowndes.
Nella numero 100 Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, uccise la sua fidanzata Nancy Spungen. Una storia d'amore finita, ahi ahi ahi, malissimo, a differenza di quella che, negli anni Sessanta, unì per poche notti soltanto Leonard Cohen e Janis Joplin e alla quale il cantautore canadese dedicò Chelsea Hotel n. 2. E infine, parlando d' amore, c'è Bob Dylan (poteva mancare una citazione per il signor Zimmerman, nel blog del tic?) che sul letto della suite principale del Chelsea scrisse una delle sue più belle canzoni, Sad eyed lady of the Lowlands, dedicata alla sua prima moglie Sara Lowndes.
